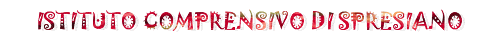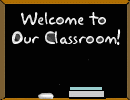|
IL CORPO INTELLIGENTE
INIZIA UN PERCORSO SFIDA
L’educazione motoria, se ben gestita, è di fondamentale importanza nel camino
dell’essere umano.
Il soggetto esprime la propria dinamicità attraverso il corpo.
La motricità prende origine da un insieme funzionale unico, personale,
indivisibile sul piano della condotta ed è parte integrante dei processi di
crescita.
Purtroppo la società non considera ancora le attività motorie al livello
delle nobili funzioni intellettive.
La sfida tende dunque a dimostrare che la gestione di sé passa attraverso la
disponibilità percettivo-motoria indispensabile per la strutturazione della
personalità.
PERCHÈ … CORPO INTELLIGENTE?
Il soggetto attivandosi in quanto insieme funzionale, esprime attraverso il
corpo la propria specificità, le proprie caratteristiche originali.
Dunque occorre un intervento educativo che fornisca l’equilibrata gestione
dell’attività funzionale mediante:
L’obbiettivo è la formazione di un soggetto disponibile nella realizzazione e
nell’operatività, con un "corpo intelligente" capace di adattarsi all’ambiente,
in ogni situazione.
LA SCUOLA ELEMENTARE
Propone situazioni educative che, attraverso l’attivazione funzionale,
favoriscono apprendimenti e produzioni sempre più ricche ed approfondite.
Permette la scoperta di sé e degli altri in campo relazionale, soffermandosi
sulle dinamiche di gruppo.
Concede opportunità per comprendere predisposizioni e propensioni soggettive,
condividendo con gli alunni percorsi d’orientamento per tendere alla
realizzazione di sé.
IPOTESI PROGETTUALE
L’educazione motoria funzionale se preposta nel rispetto della globalità
della persona, favorisce una miglior gestione di sé nei vari contesti sociali:
nella scuola, in ambito sportivo, nelle situazioni quotidiane.
SCELTE FILOSOFICHE, PEDAGOGIA E METODOLOGIE DI BASE
Le scelte dell’educatore tendono coerentemente ad un soggetto, protagonista
della propria crescita:
Capace di gestirsi ed adattarsi alle varie situazioni ambientali;
Non eccessivamente condizionato, in grado di scegliere, di agire in
autonomia ma all’occasione di lasciarsi anche giudicare;
Comunicativo, collaborativi, con controllo della sfera emotiva;
Disponibile nella relazione come nell’operatività;
Moralmente conforme alle norme sociali.
La pedagogia trova riferimento nella mediazione e nella condivisione di
momenti educativi vissuti insieme.
La metodologia alterna:
Attivazioni globali e analitiche;
Aggiustamenti spontanei e programmati;
Attenzione alla gestualità e alla postura;
Percezione di sé e di dati esterni a sé;
Apprendimenti "cercati" per imitazione e con personale elaborazione;
Ecc.
Da evitare condizionamenti rigidi, tecnicismi precoci, inibizioni
improduttive. Importanti se ben amministrate le situazioni-problema.
LE PROPOSTE EDUCATIVE
Le opportunità offerte prevedevano situazioni ed ambienti vari e stimolanti.
Le proposte sono coerenti e conseguenti alla metodologia, alla pedagogia,
alle scelte filosofiche di base.
L’attività viene offerta nel rispetto dei tempi personali.
Strutture, attrezzature, oggetti, sono scelti in base allo scopo e addetti a
rendere piacevole e multiforme l’apprendimento.
RIFERIMENTI AD ATTIVITÀ PRATICHE
Dimostrare che qualsiasi materiale può essere utilizzato per motivare
il bambino e propone giochi e situazioni con il giornale;
Tre gruppi, impiegando gli stessi attrezzi, inventano ognuno un
percorso, lo provano, lo spiegano, lo costruiscono alla lavagna, lo
dimostrano. Poi provano quello degli altri;
Controllo del corpo: entrare ed uscire dal castello di cerchi;
Supporto musicale: percezione e accordo tra il corpo e la musica,
individuale e in gruppo;
Controllo posturale da seduti al banco;
Controllo tecnico: corsa, battere con un piede in un cerchio, con
l’altro piede nel 2° cerchio e arrivo al 3°;
Equidistanze con in mano un oggetto da appoggiare al suolo per poi
verificare dall’esterno la propri posizione.
ALTRE PROPOSTE
Il gioco: poche regole, incomplete, per indurre il bisogno di
"completamento";
Il gioco: dopo averlo provato, ogni squadra si riunisce e concorda
una tattica da verificare in seguito;
Motricità spontanea e programmata: tiro della palla in un bersaglio;
Linguaggio verbale e motricità: nominare oggetti e azioni;
Scrittura: postura economica, indipendenza braccio-tronco, motricità
fine delle dita, automatismo oculo-manuale, successione lettere da
sinistra a destra
RIFERIMENTI TEORICI
L’educatore è veramente tale se da ogni situazione sa cogliere
l’opportunità per sviluppare un momento educativo.
Quando un educatore propone un attività deve essere coinvolto come se
anche per lui fosse la prima volta. Deve poter condividere l’entusiasmo
emozionale con i bambini che ha di fronte. Le proposte e le attività che
si stanno svolgendo sono vissute nel modo migliore dal bambino e
dall’educatore se tinte di colori emozionali.
Ci si esprime attraverso il corpo utilizzando linguaggi diversi. Ogni
soggetto ne privilegia alcuni rispetto ad altri. La motricità la motrice
comune dell’espressione.
Concetto di errore e concetto di imprecisione nel bambino: sono i
presupposti per chiamare in causa l’insieme funzionale per la rincorsa
al miglioramento, dunque alla crescita. Vanno quindi accettati come
salutari e con il bambino condivisi per andare oltre.
Bambini iperattivi: importanza della funzione energetica. Controllo
di sé passando per la conoscenza di sé, per le opportunità vissute, per
la propria realizzazione attraverso l’accettazione delle proprie
caratteristiche.
DOCUMENTI
Descrizione dell’incontro con i bambini:
annotazione di ciò che si attuato e di ciò che è emerso dalle varie
situazione.
Per affrontare l’incontro con competenza è indispensabile conoscere
La teoria educativa generale
Le caratteristiche dei propri alunni
Gli obbiettivi a cui tendere
e programmare, ma senza rigidità, qualche proposta di riferimento.
Scheda valutativa: descrizione per ogni bambino, delle relazioni con
gli altri e con l’operatività, tenendo presenti gli aspetti funzionale,
emotivo, morale, partecipativo.
ATTITUDINE DELL’EDUCATORE
L’adulto ha fretta, pretende subito ordine e perfezione.
Dunque non impone, accelera l’attività e non concede tentativi ed
errori, non permette autonomia, interviene subito per correggere.
Non trasformare il gioco inventivo in imitativo.
L’atteggiamento non deve essere sempre direttivo.
Ruolo: rassicurante, di stimolazione, di regolazione.
Scelta situazione-problema:
§
Livello dell’allievo
+1
§
Meglio se
inizialmente è un successo
§
Situazione con
risposte variate
Far provare anche la sana frustrazione del piccolo insuccesso, quando
non sia definitiva. Questo no deve far perdere motivazione ma al
contrario mantenere la volontà e la possibilità di trasformare
l’insuccesso in successo. Se il fallimento è costante viene a mancare la
funzione energetica (inibizione dell’azione di Laborit).
Dare opportunità di aggiustamento motorio in modo che il bambino, di
fronte ad una situazione, senta il bisogno di partecipare e di risolvere
l’eventuale problema.
Evitare che si instauri apatia,passività, ma anche che si crei una
partecipazione impulsiva, ipercinetica (instabilità).
L’aggiustamento motorio deve essere controllato. È il passaggio dalla
spontaneità iniziale ad una gestione programmata del proprio agire, pur
mantenendo la naturalezza del proprio agire. Il tono di base deve
mantenersi in equilibrio tale da permettere attenzione e vigilanza.
Questo è importante consolo nell’attività motoria ma è anche base
dell’attività mentale.
Tratto da:
Atti del Convegno
Educazione e gestione di sé
Università Cattolica del Sacro Cuore – Cremona.
|